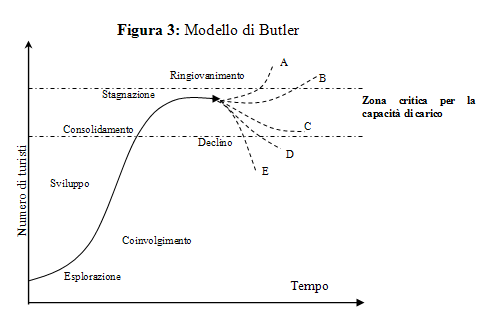Le relazioni per la sostenibilità del turismo: evidenze nelle città Unesco di Ragusa, Modica e Scicli
Facoltà di Lingua e Cultura Italiana
Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Cultura in Ambito Turistico - Imprenditoriali
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Daniela Argento
Correlatore: Chiar.mo Prof. Massimiliano Tabusi
Tesi di laurea di: Maria Velardita
2.6 - Mancata sostenibilità: quali le conseguenze?
Così come avviene per qualsiasi realtà, anche il turismo ha degli aspetti negativi che si possono verificare qualora non si ponesse attenzione a sufficienza nel tutelare la comunità residente in una località a vocazione turistica e l'ambiente naturale che la circonda. Agli stessi vantaggi indicati poc'anzi, si correlano dunque altrettanti possibili svantaggi.
Citiamo, innanzitutto, gli effetti economici negativi quali: l'aumento dei prezzi, in particolare delle abitazioni e del commercio al dettaglio; i cambiamenti nella tassazione, che costringono spesso i residenti a pagare tasse più onerose al fine di coprire i costi per la realizzazione di nuove infrastrutture o per la creazione di nuovi servizi; l'ostruzionismo delle aziende esistenti verso le nuove attività commerciali create appositamente e grazie alla maggiore capacità di spesa generata dai turisti.
A livello ambientale, invece, i rischi che si corrono sono l'inquinamento, la congestione del traffico, il rumore, il sovraffollamento e tutti i possibili danni che si possono arrecare all'ambiente naturale ed i disagi che possono irritare i residenti.
Come già detto, la comunità locale risente notevolmente degli aspetti negativi introdotti dall'attività turistica, i quali spesso sfociano nello svilimento dell'identità culturale. Tale fenomeno può essere causato dall'atteggiamento non rispettoso di alcuni visitatori, dal comportamento degli attori orientato soltanto al profitto, dallo scarso coinvolgimento degli operatori e dei rappresentanti locali nel progetto turistico. Tutte queste dinamiche potrebbero portare, inoltre, alla disgregazione sociale ed alla distorsione dell'immagine della comunità, la quale, sentendosi “invasa" dai turisti, assumerebbe comportamenti ostili nei confronti dei visitatori.
A livello politico, si rischia, invece, di assistere a comportamenti di clientelismo locale, alla distorsione delle reali finalità dei progetti turistici a fini politici, ed infine, alla cattiva allocazione dei fondi pubblici erogati.
Tutti questi possibili effetti negativi, come si può facilmente intuire, non si limitano a danneggiare unicamente l'ambiente e la comunità presenti in una determinata località, ma hanno come effetto finale quello di danneggiare il turismo stesso. Ripetendo quanto già scritto in precedenza, i turisti non si accontentano più di un buon hotel, di un ottimo ristorante dove mangiare, di bei monumenti da ammirare o di belle acque dove bagnarsi. La componente umana è ormai fondamentale nel nuovo modo di offrire turismo, per questo motivo bisogna stare attenti a non innescare nella comunità locale questi meccanismi di ostilità e rifiuto, poiché ciò avrebbe come conseguenza lo scatenarsi di comportamenti poco gentili ed inospitali nei confronti dei visitatori, portando questi ultimi a non scegliere ed a sconsigliare quella destinazione.
I danni derivanti da un mancato rispetto dei criteri sostenibili, possono rivoltarsi contro la destinazione stessa, causando la perdita della sua attrattività, un graduale deflusso di arrivi e la conseguente diminuzione dei guadagni creati dal turismo. Tutto questo si tradurrebbe in un collasso dell'economia locale, direttamente proporzionale all'importanza attribuita a questo settore, nella cessazione dell'attività turistica e nel danneggiamento di tutti gli attori coinvolti in tale ambito.
Questi esiti negativi sono stati riscontrati in diverse località turistiche sfruttate senza tener conto del rispetto per l'ambiente e per le popolazioni, motivo per cui uno dei temi centrali nel dibattito tra i cultori del turismo è diventato la vita di queste destinazioni. Diversi esperti hanno formulato teorie sulla nascita, sviluppo e declino di queste mete, evidenziando, con le loro osservazioni, il carattere relativamente ciclico che le caratterizza, grazie al quale è possibile considerare il turismo alla stregua di un qualsiasi fenomeno geografico. I principi segregativi, la specializzazione funzionale, il senso relazionale della vicinanza ed una spontanea gerarchizzazione dei centri spiegano, dunque, le modalità di uno spazio che risponde ai canoni della geografia moderna.
Alla fine, il modello che ha ottenuto il consenso più vasto tra gli esperti in materia è quello elaborato dal canadese Butler nel 1980, ispiratosi, a sua volta, al modello di vita del prodotto di Vernon (1966). Questo modello prevede la suddivisione del ciclo di vita di una destinazione turistica in sei fasi, ognuna caratterizzata da un diverso comportamento delle componenti della domanda e dell'offerta, che si riflette in termini di immagine, di valorizzazione differenziata delle risorse e di mutamento nella configurazione dello spazio turistico.
Secondo il geografo canadese, lo sviluppo turistico spontaneo inizia da una fase esplorativa che si verifica con l'arrivo di un contenuto numero di turisti “pionieri" che scoprono la destinazione. In questa fase il contatto con la comunità locale è molto intenso e manca qualsiasi forma di organizzazione dell'offerta, fatta eccezione per qualche spontanea iniziativa mirata a fornire dei servizi base per i visitatori. In questo momento l'impatto del turismo sulla destinazione è quasi irrilevante.
Successivamente assistiamo alla fase del coinvolgimento, in cui la popolazione locale inizia ad intravedere le potenzialità economiche del turismo e tende a sviluppare le prime forme di organizzazione dell'offerta. Si avvia, in questo modo, attraverso varie iniziative, la promozione della località allo scopo di espanderne i flussi. È in questo stadio che si manifesta una prima area di mercato ed un abbozzo di stagionalità. Inoltre, le difficoltà di accesso riscontrate dai visitatori per raggiungere la meta alimentano la domanda di interventi per il miglioramento delle infrastrutture.
La fase seguente è quella dello sviluppo, ovvero, il momento cruciale dell'intero percorso. Dai tempi e dalle modalità in cui questo stadio si manifesta dipende, infatti, il destino turistico di una località ed il successo o l'insuccesso delle politiche susseguenti. Durante lo sviluppo compaiono organizzazioni esterne alla località, le quali, gradualmente, andranno a sostituire l'iniziativa locale. Si dà avvio, allora, agli interventi strutturali da parte del settore pubblico riguardanti la rete viaria, gli approvvigionamenti idrici ed energetici, i servizi di pubblica utilità, ecc. Si moltiplicano anche le attività promozionali, che si estendono, ora, su scala nazionale ed internazionale. In questa fase, inoltre, aumenta notevolmente il tasso di crescita annuo dei visitatori, raggiungendo il suo apice e portando i turisti, durante la stagione, a superare il numero dei residenti. Sotto il profilo occupazionale, il turismo attira movimenti migratori e pendolari da tutta la regione circostante, non essendo più sufficiente la forza lavoro locale. Lo sfruttamento delle risorse originarie tocca il suo livello massimo, mentre l'impatto sul territorio si fa sempre più pesante. I visitatori dei primi periodi tendono ad allontanarsi lasciando il posto al turismo di massa, molto più sensibile alle capacità organizzative dell'offerta piuttosto che al mantenimento dell'ambiente originario.
Dopo lo sviluppo arriva il consolidamento, durante il quale il numero degli arrivi continua ad aumentare, sebbene ad un tasso inferiore rispetto al passato, ed il turismo tende così ad affermarsi come attività economica principale della destinazione. Compaiono, in questo modo, i primi sintomi degenerativi e l'eccessiva pressione sull'ambiente viene sempre più avvertita, mentre la riduzione del tasso di crescita stimola l'adozione di incentivi per il prolungamento della stagione turistica. Iniziano a manifestarsi anche le prime forme di opposizione nei confronti del turismo e delle sue ricadute, da parte della popolazione locale. Allo stesso tempo, la congestione ed il degrado ambientale tendono ad allontanare le parti qualitativamente migliori della domanda.
Quando subentra la fase della stagnazione, invece, il numero degli arrivi, una volta toccato il suo culmine, comincia lentamente a decrescere. La composizione della domanda registra un declino in termini di qualità, con il progressivo aumento del turismo di massa organizzato. È, insomma, il momento in cui l'eccessiva pressione turistica porta al superamento delle varie soglie imposte dalla capacità di carico. Si assiste anche alla creazione di attrattive artificiali, facendo così dipendere l'immagine della destinazione sempre meno dalle caratteristiche del luogo.
Si verifica così la fase del declino, in cui la destinazione perde in competitività rispetto alle nuove mete turistiche, il numero di arrivi diminuisce rapidamente ed il tenore qualitativo dell'offerta si abbassa in modo notevole. Questa fase potrebbe proseguire fino alla definitiva uscita della destinazione dal mercato turistico, tuttavia è probabile che le autorità locali, a questo punto, cerchino di rivitalizzare l'offerta turistica e l'immagine della località attraverso una serie di interventi di ringiovanimento. Questo potrebbe portare, a sua volta, ad un eventuale recupero, che viene generalmente perseguito tramite la creazione di attrattive complementari di natura artificiale oppure con la valorizzazione di risorse fino ad allora trascurate.
Il modello appena descritto, tuttavia, presenta dei limiti. Innanzitutto esso non tiene conto delle ulteriori fasi successive a quella dello sviluppo, che si potrebbero eventualmente verificare; ogni destinazione, infatti, dopo lo sviluppo, sembra proporre situazioni diverse. Inoltre, lo stesso parametro degli arrivi non viene considerato nella sua interezza, ma solo in modo rappresentativo, in altre parole, senza tener conto della composizione della domanda, della permanenza media e degli altri caratteri qualitativi.
L'utilità di tale modello, invece, consiste nella conseguente riflessione sulla modalità di sviluppo delle località di recente realizzazione. Le destinazioni giovani, infatti, grazie all'osservazione di questa teoria, capirebbero in anticipo i rischi di un eventuale declino futuro, motivo per cui potrebbero scongiurare una crescita spontanea incontrollata, puntando, diversamente, a stabilizzare la domanda su livelli compatibili con strategie di media e lunga durata. Anche per le destinazioni che puntano su risorse particolarmente fragili (ecoturismo, turismo archeologico, ecc.) si potrebbero ipotizzare piani di sviluppo che limitino e controllino in qualche maniera le fasi espansive, per mantenere intatto nel tempo il loro potenziale di attrazione. Lo sviluppo spontaneo, infatti, conduce spesso ad un superamento a volte irreversibile della capacità di carico di una destinazione ed al deterioramento delle risorse originali, fattori che porterebbero, nel lungo periodo, ad un prevedibile declino.
Alle fasi appena delineate è possibile aggiungerne un'altra, quella di maturità, non contemplata dal modello. Durante questo stadio, dopo una limitata discesa dei livelli massimi di successo, la destinazione deve puntare al mantenimento su livelli leggermente inferiori di una quota di mercato sostanzialmente stabile nel lungo periodo. Una politica di questo tipo richiede tuttavia un coordinamento delle strategie di sviluppo e di mercato, il rispetto delle soglie imposte dalla capacità di carico e soprattutto un tempestivo e costante rinnovamento delle risorse e dell'immagine.
Minca (1996: 24-27), per comprendere meglio il percorso effettuato dalle località turistiche, cita un altro modello proposto nel 1977 da Miossec, il quale spiega l'evoluzione strutturale di una regione turistica attraverso il tempo e lo spazio, includendovi l'analisi dell'impatto sul territorio.
La differenza tra il modello di Butler e quello di Miossec consiste nella proposta, da parte di quest'ultimo, di comprendere anche l'analisi riguardante le infrastrutture, l'offerta ricettiva, il comportamento e la percezione dei turisti, delle autorità e della popolazione locale, inserendo, inoltre, una serie di componenti qualitative. Il susseguirsi delle varie fasi si esplicita, per l'appunto, attraverso diverse prospettive ed accenna ai processi di formazione di uno spazio turistico, contemplando, altresì, i meccanismi di progressiva conquista del territorio da parte del turismo e la strutturazione che ne deriva, nonché l'evoluzione delle percezioni che se ne trae.
La critica che si può muovere al modello di Miossec, ma in realtà anche a quello di Butler, riguarda le fasi dello sviluppo turistico, le quali vengono studiate facendo riferimento ad uno spazio sostanzialmente desertico, neutro. Non compare, in queste teorie, nessun accenno alla forma territoriale esistente prima dell'arrivo del turismo, né se ne considerano i residui. Così facendo, il turismo viene erroneamente studiato come fenomeno isolato nelle sue caratteristiche specifiche e mai in relazione con gli altri elementi del territorio.
Per concludere, non si può negare che il turismo si fa interprete di forti processi di de-territorializzazione e di ri-territorializzazione, in base ai propri obiettivi, tuttavia il territorio non può essere considerato come una lavagna che si cancella con un colpo di spugna, né tanto meno, come un foglio bianco su cui poter disegnare un progetto (Minca, 1996: 27). Bisogna, allora, tener conto della persistenza di processi territoriali concorrenti o complementari, che fanno parte comunque della geografia che il turismo contribuisce a formare. Il turismo deve essere ritenuto, quindi, come parte di un sistema generale al quale si deve adattare e non come fattore a se stante, che non necessita di interagire con le componenti politiche, sociali, economiche ed ambientali che si trovano nel medesimo contesto. Nel caso in cui il settore venisse considerato isolatamente, gli svantaggi non solo si ripercuoterebbero negli altri ambiti coinvolti, ma anche a livello turistico stesso, poiché non si troverebbero più i mezzi e le risorse per portare avanti questo tipo di attività. L'ottica di profitto immediato, che guida tale atteggiamento utilitaristico ed individualista ne risulterebbe danneggiata in quanto, mancando le risorse e le condizioni per creare il prodotto turistico, anche i guadagni ne risentirebbero notevolmente, eliminando, così, tutti i vantaggi ed i lati positivi di questo settore.