Il design delle strutture ricettive private come espressione della continuità del territorio
DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA
TESI SCRITTOGRAFICA
Diplomanda: Michela Gandini
Anno Accademico 2011/2012
2.3 - I pigmenti nella tecnica pittorica dell'affresco
La tecnica dell'affresco ha origini antiche risalenti all'ultimo periodo minoico, agli Etruschi e ai Romani, che la utilizzarono ampiamente, come dimostrano i famosissimi affreschi murali di Pompei della prima metà del I secolo d.C.
Il periodo storico più importante per gli affreschi va dal tardo XIII sec. alla metà del XVI secolo, dove, proprio in Italia si possono trovare magnifiche opere di grandissimi maestri come la Cappella degli Scrovegni di Giotto a Padova; mentre del XVII sec. sono gli affreschi di seguito analizzati della splendida Villa Carlotti.
La tecnica pittorica dell'affresco, deriva da un lungo processo di perfezionamento del metodo a calce giunta all'applicazione diretta dei colori sull'intonaco fresco. Il primo a parlarcene come di un tecnica ben definita è il Cennini, la tecnica dell'affresco si basa sull'uso di due intonaci: il primo, detto arricciato, composto di calce stagionata e pozzolana viene applicata al muro grezzo come una spianatura; il secondo, detto colletta o intonaco, fatto di un impasto di rena fina di fiume e calce colata stagionata almeno un anno.
L'intonaco viene applicato consecutivamente su quelle zone del muro che possono essere dipinte nelle poche ore intercorrenti tra le prime fasi di essiccamento ed il momento in cui inizia il vero processo di carbonizzazione ed i pigmenti non sono più assorbiti nel muro, ogni strato d'intonaco che rimane non dipinto viene sminuzzato ed eliminato così che possa essere sostituito con intonaco fresco il giorno successivo.
La peculiarità dell'affresco sta nella proprietà della calce di formare in unione con la sabbia e l'acqua, un impasto in cui il colore anzichè aderire in superficie penetra, divenendo una parte integrante di esso ed insolubile all'acqua. Per far sì che le tinte si incorporino con l'intonaco, esso deve asciugare lentamente, ma il buon esito dell'affresco può essere messo in pericolo non solo dal materiale difettoso, ma anche dall'eccesso di umidità, di siccità e dai bruschi sbalzi atmosferici. Inoltre nella stesura dell'affresco c'è da tener conto che i toni chiari asciugano prima di quelli scuri e che I colori a calce non si possono usare per il ritocco, perchè mutano molto nell'asciugare ed è molto difficile calcolare questo cambiamento di tono.
Il colore vero apparirà solo dopo parecchi mesi ed a volte dopo l'anno; nonostante tutte le attenzioni è quasi certo che la calce causera l'apparire di macchie e stonature nei colori, per cui la grande maggioranza degli affreschi ha bisogno di essere ritoccata.
L'aspetto finale del vero "affresco" è severo ed inconfondibile, dovuto a quello smalto che acquista il colore quando è combinato con la vetrosità della calce, conferendogli un tono leggermente più scuro ed intenso di quello che ha la tempera e presenta il caratteristico particolare di far apparire i toni più intensi quanto più ci si allontani da essa, proprietà che perde quando la si ritocca a tempera o olio.
In base alla loro origine, i pigmenti sono distinti in naturali e artificiali ed, in base alla loro composizione, in chimici, organici o minerali. I pigmenti inorganici naturali più antichi, maggiormente noti, ed ancora oggi molto usati sono le terre coloranti naturali, questi colori antichissimi sono indispensabili per la tecnica dell'affresco e utilissimi per tutte le altre tecniche pittoriche. Si tratta di sali, acidi, solfuri, presenti sotto forma diversa, nel suolo, in giacimenti più o meno profondi con stratificazioni di vario tipo, dipendenti dall'era geologica che consenti la loro formazione.
Le principali tecniche per la preparazione sono la macinazione di minerali, la cottura di sostanze animali o vegetali ed i vari processi chimici utilizzati per produrre i vari colori. I diversi tipi di lavorazione determinano anche il tipo di potere coprente di un pigmento, infatti esso è direttamente proporzionale alla forma ed alla finezza dei suoi grani ed al loro indice di rifrazione. Non tutti i pigmenti possono essere usati indifferentemente con le varie tecniche pittoriche, infatti, nell'affresco possono essere utilizzati solo quelli più permanenti, specialmente per le opere esterne. I pigmenti più stabili, che mutano meno nel tempo, sono ricavati dalle ocre e dalle terre, che forniscono una vasta gradazione di gialli, rossi, bruni e verdi.
I colori da evitare, perchè poco resistenti alle intemperie o all'azione della calce sono:
- Cinabro, minerale dall'aspetto rossiccio;
- Minio, minerale di colore bruno rossastro utilizzabile solo per la pittura su tavola;
- Rosso sangue di drago, troppo poco resistente per l'affresco;
- Rosso color sanguigno, adatto solo per la pittura a tempera;
- Giallo orpimento, che ha una buona resa di colore, ma è soggetto ad annerire;
- Biacca di piombo, unico altro bianco oltre a quello Sangiovanni, ma utilizzabile solo per dipingere su tavola;
- Verde di Verona, fa parte dei colori da usare con attenzione va usato molto puro per non scolorire;
- Orpimento, meno usato dell'ocra gialla probabilmente perché tossico e meno adatto all'affresco;
- Oltremare naturale messo a tempera, come facevano gli antichi, si sfarina, per cui non va bene per l'affresco;
- Nero d'avorio stenta ad unirsi all'acqua e va prima macinato con l'alcool, poi fatto seccare.
Mischiando i colori tra di loro si possono ottenere varie tonalità e gradi di saturazione, ma negli affreschi il colore tende ad essere utilizzato prevalentemente puro. I requisiti più importanti erano due: luminosità ed intensità; ovvero i colori erano applicati con una forte saturazione, senza sfumature e mezzitoni, per sottolineare il potere espressivo, necessario a risaltarne il significato simbolico.
I colori adatti all'affresco, individuati da Cennino Cennini, sono già stati usati nel Medioevo da Giotto e dalla sua scuola, e con poche variazioni, verranno usati per tutto il rinascimento e fino al XIV sec da tutti i grandi decoratori, fino a che non verranno sostituiti, in gran parte con i colori odierni.
I colori utilizzati al giorno d'oggi sono prevalentemente chimici, anche se si fa ancora largo uso di tutte le terre e dei colori naturali, le tinte moderne generalmente sono più resistenti e dalle tinte vivaci, presentando una gamma di colori ben più vasta che in altre epoche, anche se, come afferma L. Branzani nel suo libro Le tecniche la conservazione il restauro delle pitture murali "Nelle pitture, specialmente murali, credo sia preferibile il minor numero di colori, [...] ma dobbiamo pur ammettere che sono ormai lontani i tempi in cui quattro colori, compresi il bianco ed il nero, potevano bastare ai grandi pittori greci per rendere immortali le loro opere."
NERO
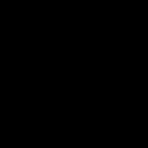
Il nero si fabbricava o con il fumo o carbonizzando tralci di vite,oppure si trovava allo stato naturale di pietra. Questo colore non compare nelle vesti dei personaggi dipinti, è riservato solo per i vestiti dei chierici, le tonache dei Benedettini e per i diavoli (altrimenti rappresentati con pelle pelosa di animali). Se l'assenza di luce del nero nel manto benedettino aveva valenza positiva di rinunzia alle attrattive del mondo, associato all'umiltà e di conseguenza alla pazienza, temperanza nel dolore; era anche il colore del male che respingeva la luce, per questo utilizzato nella simbologia anche per i diavoli.
I valori di lusso, eleganza come quelli di lutto che, ai giorni nostri, si associano al nero, nell'Italia medievale erano sconosciuti.
ROSSO SINOPIA

Rosso sinopia, ricavato da una terra naturale che mischiata col bianco di calce dava un colore detto cinabrese, ma poco adatto per l'affresco perchè annerisce al contatto della calce. La parola prende nome da una terra rossastra presente nei pressi della città di Sinope (colonia greca nel Ponto) ma si ritrova anche in Egitto, Baleari, nord Africa ed in Cappadocia.
Se prodotta per calcinazione dell'ocra in vasi nuovi, veniva chiamata rubrica e con tale nome il pigmento era usato in Grecia (Apelle).
ROSSO CREMISI

Il rosso è il colore che, con all'azzurro oltremare, domina le composizioni cromatiche della pittura trecentesca su tavola. Azzurro e rosso hanno il primato dell'intensità e della brillantezza rispetto ai colori che si possono ottenere dalle terre ma, mentre la fortuna del primo, è piuttosto recente, il rosso vanta una tradizione antichissima di assoluto prestigio nella gerarchia dei colori. Assieme al nero era considerato fino al Medioevo un contrario del bianco: rispetto alla contrapposizione luce/oscurità della coppia bianco/nero, il contrasto bianco/rosso assumeva un significato assai prossimo a quello di colorato/non colorato, particolarmente nell'antica Roma dove spesso gli abiti degli uomini adulti venivano tinti con una gamma estremamente ampia di toni rossi.
GIALLO OCRA

A partire dal XIII secolo, con l'affermarsi deciso dell'oro come valore assoluto, il giallo assume un significato negativo, delineandosi come una degenerazione delle qualità materiali, luminose e morali dell'oro. La coppia cromatica giallo/verde distingueva anche i folli, i buffoni, e, quanto più il giallo tendeva al verde, tanto più era considerato negativo. Il giallo, specialmente nel suo più alto grado di saturazione e luminosità, può assumere però anche una valenza positiva o, quantomeno, neutra come dimostrano le vesti gialle comunemente attribuite ad alcuni santi come San Giuseppe o San Pietro.
GIALLORINO
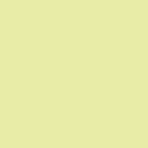
Pigmento giallo artificiale, velenoso, si tratta infatti di stannato di piombo. E' un colore pallido tra il giallo limone e il giallo medio (in base alle caratteristiche del processo di fabbricazione). Si ottiene calcinando a circa 800 °C, in crogioli chiusi, una miscela di due parti di biossido di stagno e tre parti di minio di piombo.
Come pigmento è stato utilizzato ad affresco e ad olio (in particolare tra il 1500 e il 1750), trovando inoltre impiego nell'arte del vetro e della ceramica. Come tutti i composti di piombo asciugano molto rapidamente se mescolati in olio e anneriscono se messi a contatto con composti di zolfo; non vengono alterati dalla luce, a differenza del giallo di ossido di piombo.
VERDE TERRA

Verde terra, ottimo per ogni tecnica di pittura, che veniva usato in origine per applicare l'oro sulla tavola. La terra verde è un pigmento ottenuto dai minerali, già noto a Greci e Romani e fu utilizzato durante il Medioevo e il Rinascimento.
È composto principalmente da silicati ferrosi e ferrici di potassio, manganese e da ossidi di ferro, potassio e alluminio. Cennini afferma che una miscela di zafferano e verderame produce «un colore più perfetto che si truova in color d'erba».
BLU OLTREMARE

Azzurro oltremarino, colore assai costoso e raro, ottenuto con la macinazione della pietra di lapislazzuli e che si adoperava misto a colla sia su tavola che sia su muro. Dal XIII secolo il colore che simboleggia il più alto grado di nobiltà, non solo in pittura, è il blu, metafora di spiritualità e trascendenza; ma nella pittura murale, il blu veniva usato generalmente per gli sfondi I pigmenti blu erano essenzialmente due: l'oltremare, il più prezioso (ottenuto dai lapislazzuli), e l'azzurrite. La distanza da cui arrivava il minerale blu del lapislazzuli e il difficile procedimento preparatorio lo resero molto costoso e, quindi, anche molto apprezzato, infatti, proprio per il suo costo, era considerato uno dei colori più ricchi e preziosi, associato al rosso porpora e all'oro, in particolare nell'iconografia della Vergine. I pittori lo usavano con parsimonia sostituendolo spesso con un altro pigmento, più economico, l'azzurrite.
BIANCO SANGIOVANNI
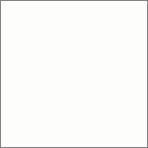
Bianco Sangiovanni, fatto con la calce è indispensabile per dipingere gli affreschi. Il bianco, nella valutazione cromatica medievale, come il nero, è percepito come un'assenza di colore e, come tale, è spesso associato alla morte e al lutto: bianchi sono i sudari e le bende che avvolgono i defunti. Conseguentemente diventa anche il colore di chi si appresta a mutare condizione, a transitare fisicamente o spiritualmente da una fase all'altra della vita. Bianco quindi è anche il colore degli angeli.